
1995 - 2025: Cultura e Sviluppo compie trent'anni
“Cultura e Sviluppo compie trent’anni!
Questi trent’anni non raccontano solo la storia di un’associazione, ma di una comunità che ha imparato a crescere insieme alla città.
Cultura e Sviluppo non è soltanto una sede, ma una rete viva di persone, di relazioni, di idee che si incontrano, cambiano forma, e che soprattutto continuano a generare futuro. Da trent’anni, sotto le sue vetrate, si intrecciano dialoghi, progetti, percorsi professionali e umani che hanno contribuito a farne un luogo unico di partecipazione e cultura condivisa.
Il trentennale sarà l’occasione per ripercorrere questo cammino collettivo: non una vuota celebrazione di sé, ma uno sguardo sulle persone che, giorno dopo giorno, hanno dato voce e sostanza a un’idea di cittadinanza attiva, di cultura come bene comune, di incontro come motore di cambiamento. Proprio perché Cultura e Sviluppo è prima di tutto persone che fanno insieme, e non c’è una sola voce che possa raccontare questo traguardo, ma centinaia, Salvatore Falzone, autore e collaboratore dell’associazione, realizzerà per l’occasione un racconto corale fatto di voci, immagini, e memorie – un mosaico di vite che, da trent’anni, compongono la storia di Cultura e Sviluppo”.



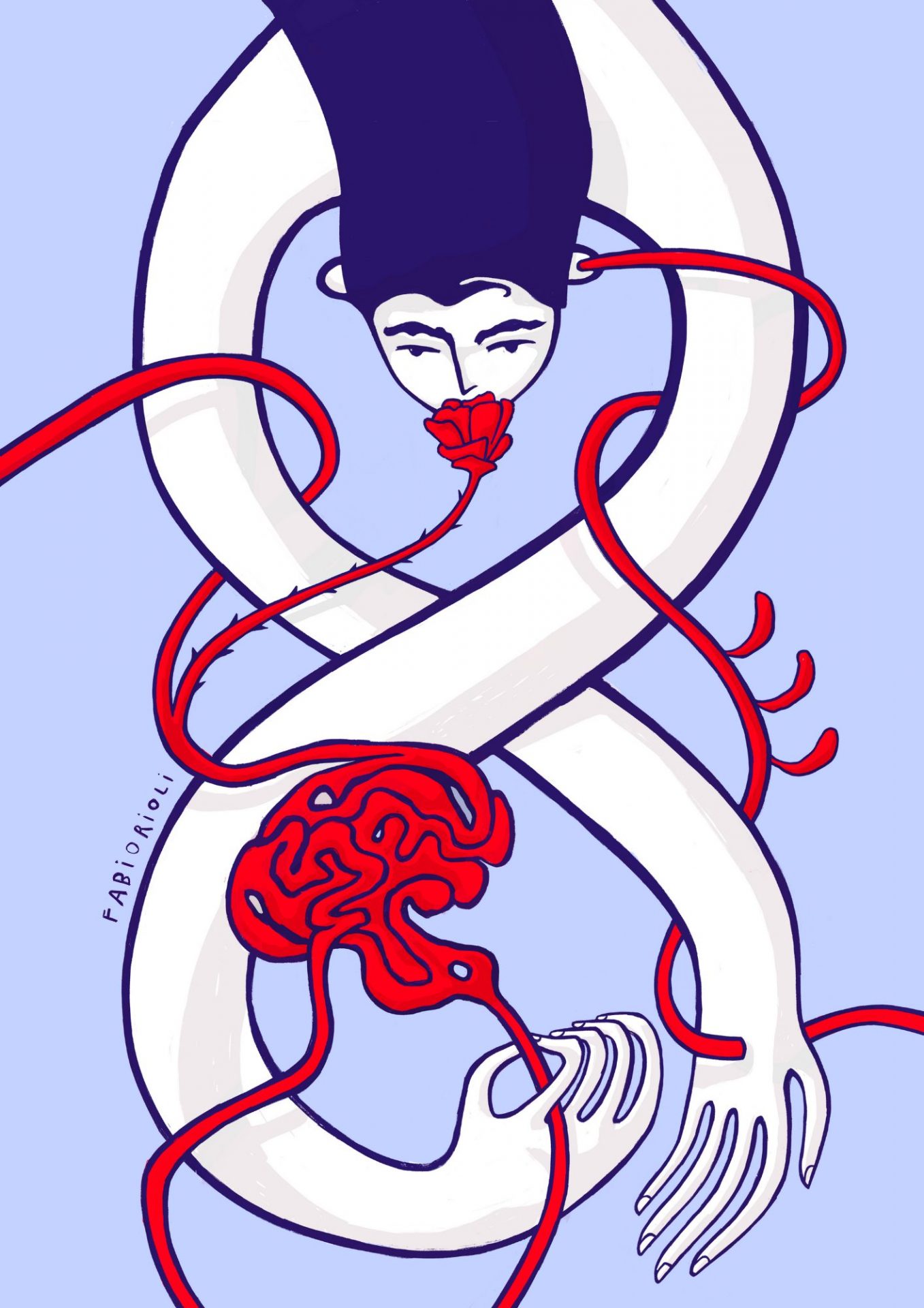
Breve storia umana di un'associazione
Salvatore Falzone
Nota dell’autore
Il racconto che segue nasce da una serie di interviste reali condotte con lo staff di Cultura e Sviluppo in occasione del trentennale dell’associazione.
Sebbene i personaggi e gli episodi narrati si ispirino a persone e fatti realmente esistiti, ciò che qui si narra non è e non vuole essere una cronaca ma un racconto letterario a più voci sul passato, il presente e il futuro di Cultura e Sviluppo.
Parole, pensieri e azioni dei protagonisti, anche quando provengono da testimonianze vere, appartengono perciò al regno della finzione.
Ci tengo a ringraziare tutto lo staff dell’associazione (e chi con l’associazione collabora) per la fiducia, la disponibilità e la generosità con cui ha condiviso con me ricordi, idee e frammenti di vita.
Capitolo 1
Ben vengano le briciole
Entrando in macchina nel parcheggio, la sede sembra una lastra di vetro e metallo piantata nel cemento. Questa, tra l’altro, è stata la sua impressione quando l’ha vista per la prima volta. Alle spalle dell’edificio, nel cielo si rimescolano il rosa e l’azzurro. È ancora presto, e il quartiere è mezzo assopito. Il supermercato, pochi metri più in là, ha aperto da mezz’ora appena; ci sono poche auto parcheggiate, solo un paio di persone spingono i loro carrelli verso le porte automatiche.
Nicola, con la borsa frigo che gli sbatacchia contro il fianco sinistro e la custodia del pc contro il fianco destro, attraversa il parcheggio. Si muove come ogni mattina: una volta entrato, disattiva l’allarme, apre le porte d’ingresso, poi procede verso gli uffici. La sede è vuota, silenziosa, i corridoi ancora bui. Lascia la custodia del computer in ufficio, la borsa frigo sul tavolo in cucina, va alle macchinette con il cappotto ancora su. Mentre aspetta il suo caffè, picchietta un piede sul linoleum.
È l’ultimo arrivato nello staff. Prima del suo colloquio per il Servizio Civile Universale, non era nemmeno a conoscenza dell’esistenza di Cultura e Sviluppo; l’ha scoperta per caso, cercando il progetto più vicino a casa. Il giorno del colloquio è entrato nella sede trattenendo il respiro: l’edificio gli era parso elegante ed enorme, tutto vetro, scale, colonne, luce – sproporzionato rispetto all’idea che aveva di un’associazione. Poi ha conosciuto Alessio, il direttore, un paio di sneakers giallo fluorescente ai piedi, e prima di entrare nel suo ufficio ha dato un’occhiata al corridoio che si allungava alla sua destra, dove delle voci si chiamavano da una stanza all’altra. Il suo nervosismo si è come dissolto.
Mentre mescola il suo caffè, torna in atrio. Gira intorno a una colonna, poi un’altra. Apre le porte del salone, che è ancora immerso nell’oscurità – solo qualche spia, in fondo, lampeggia. La luce che proviene dall’atrio rischiara le prime file di poltrone rosse. Beve il primo sorso di caffè, poi si lascia il salone alle spalle. L’atrio lo attira di nuovo a sé, come se fosse quello il centro di tutto; ci rimane qualche minuto, il tempo di finire il suo caffè. Entrano un paio di studenti, facce a lui familiari; lo salutano prima di salire al piano di sopra dove, tra tavoli e prese elettriche, cominceranno a studiare.
Mentre li guarda, Nicola ripensa a qualche giorno prima, quando in atrio ha stretto la mano di Francesco Guala, il presidente dell’associazione. Veniva da Milano, dove insegna.
Qualcuno ha detto a Nicola che la prima cosa che aveva deciso Francesco Guala una volta diventato presidente era stata lasciare spazio. Fidarsi delle persone che non solo rappresentavano l’associazione ma la facevano tutti i giorni. Lui avrebbe garantito una continuità di visione, certo, ma Cultura e Sviluppo erano prima di tutto i membri dello staff, i collaboratori, i giovani che frequentavano gli spazi.
Alessio l’ha accompagnato su; riuniti a piccoli gruppetti sul soppalco gli studenti stavano già studiando. Francesco li ha guardati, ha guardato i portatili aperti, le cuffie, le borracce sul tavolo e per terra; Nicola, preoccupato, si è strappato due o tre pellicine dalle dita. Le briciole, ha pensato. Era vietato mangiare dove c’era la moquette, ma qualcuno talvolta trasgrediva, magari perché era la prima volta che frequentava l’associazione e non aveva letto le regole stampate sul foglio appiccicato al tavolo.
«È bello vederla così» ha detto Francesco, al ritorno dalla sua visita al piano di sopra. Sorrideva. «Viva, abitata».
Secondo lui, oggi che gli spazi di socialità – non quelli privati ma quelli che tutti attraversano – si sono ridotti o sono addirittura spariti, oggi che la sfida è tirar fuori le ragazze e i ragazzi dalle loro case, è cruciale trovare nuovi modi di agganciare i giovani, di fare in modo che si guardino in faccia e si parlino e facciano cose insieme; quindi ben vengano le briciole, perché in fondo testimoniano un passaggio. Era una gioia per lui vederli entrare, uscire, fermarsi.
Uscendo, si è fermato un attimo in atrio, ha sollevato lo sguardo. Forse vedeva per la prima volta le nuove vetrate colorate di rosso, giallo e blu.
Nicola l’ha guardato in silenzio; che effetto doveva fare, aver seguito la traiettoria esistenziale di un’associazione da quando era ancora un’intuizione nella testa del padre?
Che l’associazione era nata da un momento di sconfitta lo sapeva, gliel’avevano raccontato. Cultura e Sviluppo era arrivata dopo una cocente delusione politica vissuta in primo luogo da Roberto Guala – ma anche da Francesco, che alla campagna aveva contribuito. In quel clima di disincanto generale Roberto Guala aveva pensato che se la politica diretta non aveva funzionato allora avrebbero dovuto trovare altri modi di impegnarsi, non più dentro i partiti ma prima dei partiti: c’era bisogno di formare persone competenti, curiose, che si spendessero per la loro città.
Sono passati trent’anni da quel momento.
Ora anche Nicola guarda in alto, le ampie vetrate colorate di rosso, giallo e blu, colori che la luce del giorno proietta sul pavimento e le scale. Qualcuno, forse Deborah, gli ha detto che le vetrate le avevano volute Piergiacomo Guala e il suo amico architetto Gianni Giacchero, insieme avevano immaginato una nuova sede piena di luce, trasparente, con grandi superfici di vetro. Piergiacomo aveva addirittura pensato a un binario sopraelevato per pulirle facilmente, come si fa nei musei. Il binario non era stato realizzato, ma il vetro era rimasto. Deborah gli ha raccontato di aver visitato la sede quando era ancora un cantiere; prima di un Giovedì Culturale, le planimetrie stese su un tavolo, Piergiacomo le aveva chiesto: «Ma tu…
Capitolo 2
Entrerà tutta la luce che serve
…non l’hai mai vista?».
Deborah, che questa nuova sede non l’ha mai vista e non è nemmeno in grado di immaginarsela, dice di no. Dalle planimetrie disposte sul tavolo intuisce solo che dev’essere uno spazio enorme, molto più grande di quello in cui lavorano ora, ma non riesce a immaginarsi come sarà organizzato.
«Sa’, allora andiamo» dice Piergiacomo.
«Adesso?» chiede lei. Lancia un’occhiata all’orologio appeso alla parete: manca un’ora all’inizio dell’evento.
«Ma sì, adesso» risponde lui.
Le ha già dato le spalle. Deborah lo segue fuori e insieme montano sulla sua Jaguar. A lei Piergiacomo piace; le piace il modo in cui, quando viene in sede, seduto di fronte a lei allinea con cura i fogli e le penne sulla scrivania, le piace la sua praticità – prima di incontrarlo mai avrebbe pensato che un imprenditore come lui potesse inginocchiarsi sul pavimento di un ufficio per rimettere un cassetto nei binari.
Deborah non è nata ad Alessandria, e prima di trasferircisi da Torino non aveva idea di quanto il cognome Guala pesasse in città. Per questo, quando suo marito le aveva detto che Giorgio Guala sarebbe stato loro ospite a cena, lei non aveva battuto ciglio. Aveva pensato, semplicemente, che si trattasse di un vecchio amico di famiglia. Non ricorda bene quanto tempo sia passato da quella cena – forse due, tre anni? – ma ricorda perfettamente l’impressione che le aveva fatto Giorgio, soprattutto quando a tavola aveva cominciato a parlare dell’associazione fondata da lui e i suoi fratelli, un’associazione che non proponeva solo eventi culturali ma anche un percorso di formazione per ragazzi. Diceva che lei sarebbe stata perfetta per quel progetto, un’ottima tutor, ne era certo; e mentre parlava, il suo entusiasmo pareva elettrizzare l’aria attorno a sé. Qualche mese dopo si era rifatto vivo: Cultura e Sviluppo voleva proporre dei corsi di lingue, le sarebbe piaciuto tenere quello d’inglese? Così aveva conosciuto Elena; si erano incontrate fuori dalla sede, lei era carica di borse della spesa e le aveva detto: «Tempo di mettere gli yogurt sul termoconvettore e ci facciamo due chiacchiere, che ne pensi?».
Ora insieme a Piergiacomo entra nella futura sede di Cultura e Sviluppo. Circondata da mattoni, cemento e tubi scoperti, fa ancora più fatica a immaginarsela finita. L’odore della calce fresca si mescola a quello ferroso del cantiere. I loro passi risuonano vuoti mentre Piergiacomo le fa strada, indicando gli spazi che ancora non esistono. Da una parte c’è il salone, già parzialmente sistemato, dall’altra la scalinata, l’ascensore, le vetrate alte fino al soffitto. Quelle vetrate ora sono coperte da uno spesso strato di polvere, ma la luce filtra ugualmente – opaca, lattiginosa, come acqua torbida.
Per un momento restano fermi lì, in silenzio, ad ascoltare il ronzio lontano di un trapano. Poi Piergiacomo dice: «Vedrai, quando sarà finita. Entrerà tutta la luce che serve».
Deborah ripensa a quella cena in compagnia di Giorgio Guala, a come il suo entusiasmo l’ha contagiata. Aveva contagiato anche Elena, gliel’ha detto lei; una sera Giorgio era passato a trovarla, probabilmente per parlare con Piergiacomo, che poi era suo suocero, e i due avevano chiacchierato un po’, «ha questo modo di parlarti che ti coinvolge subito, che ti fa venire voglia di fare le cose» ha detto a Deborah, e lei era d’accordo. Giorgio si era illuminato mentre le parlava dell’associazione, e quella luce si era trasferita da un corpo all’altro, lei se l’era portata dietro per giorni, non faceva che pensarci. Alla fine, confrontandosi con Piergiacomo, lui le aveva detto, stringendosi nelle spalle: «Eh, t’ha fatta su».
Quell’idea – perché prima di essere un posto Cultura e Sviluppo era un’idea – aveva una sua innegabile luminosità. Una luce sottile, elettrica, che passava da una persona all’altra come una corrente silenziosa. Ogni volta che se ne parlava sembrava crescere, farsi più chiara, più urgente. Aveva la qualità delle cose necessarie, di quelle che esistono già – o che quantomeno dovrebbero esistere – anche se ancora non hanno preso forma.
Quando Elena era entrata per la prima volta nella sede per lavorarci, le era sembrata un posto vivo, un posto che aveva un suo respiro. C’era sempre qualcuno che passava, che ti salutava, che ti chiedeva se avevi bisogno di qualcosa. Era un modo diverso di abitare un posto di lavoro. Anche negli anni successivi avrebbe continuato ad avvertirlo, quel respiro – come aria che si muove tra le pareti. Davide, più di ogni altro, avrebbe confermato quella sensazione: anche secondo lui la sede di Cultura e Sviluppo viveva, te ne accorgevi soprattutto quando era vuota, perché non lo era mai del tutto, ogni stanza aveva un suo rumore, un suo ritmo.
Che l’idea originaria, quella luce che l’aveva accesa fin dall’inizio, avesse trovato modo di trasferire la propria vitalità ai muri, ai pavimenti e ai corridoi?
La breve gita è finita, e così Deborah e Piergiacomo si dirigono verso l’uscita; lei, qualche passo più indietro, una volta fuori si volta a guardare la sede. Le pare ancora incredibile che a breve si trasferiranno in quel posto enorme. Come faranno a riempirlo?
Comunque, non ha senso pensarci ora; dà le spalle all’edificio e, accelerando il passo per star dietro a Piergiacomo, attraversa…
Capitolo 3
Una scommessa sul tempo
… il piazzale, il casco della moto appeso al polso, e poi entra. Ad accogliere Alessio c’è un silenzio, un torpore tipico di quei giorni di festa. Gennaio è appena cominciato, e la luce che filtra dalle vetrate è bianca, quasi metallica.
Dentro il suo ufficio, che più che un ufficio ha l’aria di essere una stanza di passaggio, appoggia il casco sulla scrivania – due tavoli di legno uniti – e si toglie i guanti. Tira fuori dallo zainetto il portatile e sistema anche quello sulla scrivania.
Per un po’ resta immobile, come a voler capire da dove iniziare. Si guarda intorno, guarda gli scaffali e le sedie di plastica verde intorno a lui, e ha la sensazione che tutto, lì dentro, sia come in attesa. Da giorni avverte dentro di sé non un entusiasmo – perché l’entusiasmo ha vita breve – ma un’energia, un passaggio di corrente; non poteva restare a casa, doveva essere qui, e se potesse monterebbe sulla moto e andrebbe a recuperare tutti gli altri membri dello staff, direbbe loro che non è il momento di poltrire, quello, ma di mettersi al lavoro.
È direttore di Cultura e Sviluppo da qualche anno, ormai, ma non ricorda di aver mai provato una sensazione simile, nemmeno quando la famiglia ha accettato la sua proposta di aprire un giornale, AlessandriaNews, di cui era direttore editoriale. Quelli del giornale sono stati anni intensi, febbrili; era come essere dentro un grande laboratorio, si lavorava guidati dall’idea che informare fosse anche costruire senso civico, non solo fare notizie.
Ora che non è più direttore di AlessandriaNews, però, sente di poter finalmente dare il meglio di sé dentro quel piccolo mondo che è Cultura e Sviluppo, dove già convivono Marco C. e Marco M., che come lui hanno lavorato sia nel giornale sia in associazione, e presto comincerà la ricerca di altri esseri umani, e una volta costruita quell’intelligenza collettiva si potrà cominciare a progettare, ma progettare davvero.
Non può e non vuole stare fermo, una lezione che ha appreso dai fratelli Guala, soprattutto dai due imprenditori, Roberto e Piergiacomo: stare fermo significa morire, significa rinunciare a crescere, ad avere futuro. D’altronde è così che è nata Cultura e Sviluppo, da un’intuizione fulminea, una fiammata di Roberto Guala: forse un’associazione culturale era la risposta più efficace a un momento di grande scoramento civile, in cui la politica sembrava non bastare più – la sconfitta alle elezioni l’aveva dimostrato. Cultura e Sviluppo, nella sua testa, riusciva a tenere due movimenti complementari: da una parte la cultura pubblica, con incontri, discussioni, conferenze, e dall’altra la formazione dei giovani, che poi avrebbe affidato a suo fratello Giorgio.
Era, in fondo, una scommessa sul tempo: trasformare la città trasformando chi la abita.
Alessio si siede, apre il portatile, lo accende. Mentre attende la comparsa del desktop, appoggia i gomiti sulla scrivania, unisce le mani e ci accosta il mento. Fuori, la città è ferma: si sente solo, lontano, il suono di un camion che fa retromarcia.
Gli pare di sentirla vibrare, la sede: come se le pareti stessero assorbendo quell’energia nuova. Non è un inizio qualsiasi, si dice; è un punto di convergenza – tutto ciò che è venuto prima ha trovato, all’improvviso, una nuova direzione.
E lui sente che può tenere tutto insieme: le persone, i progetti, le cose che ancora non esistono.
Per qualche motivo, ripensa a Giorgio Guala. Ricorda con precisione il momento in cui l’ha incontrato per la prima volta: frequentava il quinto anno di liceo, si trovava nell’aula magna dell’Istituto Volta insieme ad altri studenti, la maggior parte dei quali attratti dal cognome Guala e dal sogno di scalare la piramide sociale, ma non lui, lui era lì perché sua madre aveva letto su Il Piccolo che esisteva il Progetto Giovani, descritto come un percorso biennale per ragazzi e ragazze del territorio, scandito da incontri con esperti, momenti di formazione ed esperienze di gruppo; gli aveva detto che non poteva assolutamente mancare, e così Alessio quella mattina è entrato controvoglia nell’aula magna già gremita di ragazzi, le giacche buttate sulle sedie e gli zaini abbandonati sul pavimento. Giorgio Guala, ovviamente, si è rivelato diverso da come Alessio si era aspettato: parlava di dinamiche di gruppo e di quelle che oggi vengono chiamate soft skills, parlava di esperienze d’impresa in cui a contare non era la gerarchia ma il gruppo di lavoro – parole che allora suonavano strane ma che oggi, a distanza di anni, tornano come profezie. Poi Giorgio ha parlato del Progetto Giovani, spiegando che durante il secondo anno si poteva progettare qualcosa da realizzare sul territorio, e Alessio si è proteso in avanti, interessato. Ecco cosa l’ha agganciato in maniera irreparabile: Giorgio Guala sembrava crederci davvero, in ciò che diceva.
Alessio si è iscritto al Progetto Giovani il giorno dopo.
Ricorda ancora il colloquio; allora era Marzia a tenerli, lei che insieme a Giorgio B. alla nascita del Progetto Giovani aveva assistito e contribuito.
Giorgio, in particolare, seguiva l’associazione fin dai primi Giovedì Culturali, che in realtà nemmeno si chiamavano ancora Giovedì Culturali: erano degli incontri seminariali in cui si discuteva di questioni locali. Prima c’era la relazione a cura di un esperto, poi una pausa buffet e infine il dibattito vero e proprio – una formula che l’associazione si era portata dietro per decenni. Allora a partecipare al dibattito erano quindici, venti persone, gli Amici di Alleanza Democratica. Giorgio ne aveva frequentati diversi perché già conosceva Giorgio Guala, che teneva all’università un corso sulle metodologie dell’apprendimento e, su sollecitazione di Roberto, aveva chiesto ai suoi studenti se qualcuno fosse interessato a spendersi un po’ per la città.
Ecco cos’era stato il Progetto Giovani prima di diventare il Progetto Giovani: un piccolo gruppo di universitari che si trovava dove capitava, la sera, per discutere di come riaccendere la città in cui vivevano. Non c’erano ancora sedi, solo tavoli improvvisati, fogli pieni di appunti e la sensazione, sempre più concreta, che da quelle conversazioni potesse nascere qualcosa di reale. Poi Giorgio Guala aveva fatto da catalizzatore: dopo aver ascoltato con attenzione le proposte del gruppo, aveva ideato quella che per gli anni a venire sarebbe stata la struttura del Progetto Giovani, un canale attraverso cui la maggior parte dello staff di Cultura e Sviluppo sarebbe passato, anche Marco M., che tuttora è tutor, anche se inizia a sentire il dislivello anagrafico con i ragazzi. Una volta, durante una riunione di staff, ha detto che il Progetto Giovani, invece di dargli la mazzata finale dopo la giornata lavorativa, lo rinvigorisce; ha ricordato il suo primo colloquio con Marzia, ha detto che addirittura lei…
Capitolo 4
Una forma di riconoscimento
…è tentata di espellerlo dal Progetto.
Francesca non ha idea di cos’altro fare. Le assenze – che ci sono state, e sono state troppe – non sono l’unico fattore da tenere in considerazione. Quel ragazzo non vuole partecipare alle attività, e se partecipa alle attività lo fa passivamente, le braccia a penzoloni lungo i fianchi e le labbra una riga dritta sulla faccia. Il gruppo è cresciuto senza di lui, sputandolo fuori come un organo estraneo.
Ha provato a parlarci, ma lui alle sue domande ha risposto a monosillabi, stringendosi nelle spalle. Ha provato a proporre al gruppo attività che richiedono la partecipazione attiva di tutti i partecipanti, anche i meno collaborativi.
Niente.
Proprio non riesce a capire, lei che dal Progetto Giovani è stata salvata. Ricorda ancora la mattina in cui Marco M. e Valentina hanno varcato la soglia della sua classe e hanno parlato del Progetto Giovani; lei ha pensato che era perfetto per lei, non solo perché non praticando sport era alla disperata ricerca del credito scolastico, ma anche perché quell’esperienza le avrebbe permesso di restare al margine, come d’altronde già faceva quando si trovava insieme ad altri: non era un’estroversa, non era una che in pubblico parlava facilmente, non era una che si esponeva, e per queste ragioni non è mai stata rappresentante di classe.
Poi il Progetto Giovani è iniziato, e con il tempo lei – insieme agli altri membri del suo gruppo – ha scoperto che entrando nella sede di Cultura e Sviluppo diventava un’altra. Avevano tutti personalità e idee molto diverse, ma quando si trovavano nello stesso spazio, spesso in cerchio, non erano più loro. Era come se, uno di fronte all’altro, abbandonassero le loro identità dai confini ermetici per diventare qualcosa di comune – un corpo collettivo che respirava in sincrono, un insieme di voci che si cercavano e si correggevano a vicenda. Ecco cos’erano, in fondo: una comunità in miniatura. In quelle ore, ognuno di loro smetteva di essere soltanto sé stesso. Nella testa di uno c’era uno spazio riservato anche al gruppo. Non si trattava di perdere la propria voce, ma di scoprire che la voce, da sola, non basta mai.
Ecco cosa dice ai suoi ragazzi ora che è tutor: «Mi sono iscritta per il credito, sono rimasta per tutto il resto».
E se non avesse partecipato al Progetto Giovani, prima come tutorata e poi come tutor? Chi sarebbe ora? Se lo chiede spesso, ma non riesce a rispondersi; non solo perché il Progetto Giovani le ha permesso di conoscere l’ente che poi l’avrebbe assunta, ma soprattutto perché lì, per la prima volta, ha potuto toccare con mano il suo potenziale. Un tempo aveva l’abitudine di restare in silenzio finché le conversazioni non si erano esaurite, come se la sua voce fosse solo un’interferenza; poi, a poco a poco, si è concessa d’intervenire, di proporre, e perfino di protestare.
Del ragazzo parla a Marco M. Lui, le gambe accavallate e una mano accostata al viso, ascolta senza interromperla. Annuisce, a volte dice: «Mmm». Poi, quando Francesca ha finito, le chiede: «Ma tu lo sapevi che io durante il mio primo anno di Progetto Giovani ho fatto più assenze che presenze?». Francesca risponde di no, e onestamente mai avrebbe potuto pensarlo: per lei, Marco è uno dei pilastri del Progetto Giovani. Ma vuole sapere di più di quel primo anno problematico, e così Marco le racconta del suo professore di storia e filosofia del liceo, Giuseppe Rinaldi, le dice che è stato lui a parlargli del Progetto, alla fine di una discussione in classe intorno a una questione politica che oggi ha completamente dimenticato. Rinaldi gli ha detto che trovava quel dibattito molto interessante ma non c’era tempo per continuarlo lì in classe; forse, però, Marco – e si rivolgeva a lui in particolare perché era quello che, durante le discussioni, più s’infervorava – avrebbe apprezzato un percorso del genere, che prevedeva, oltre ad attività di gruppo, dibattiti intorno a conferenze. Marco, che di Rinaldi si fidava, si è iscritto a quella che di fatto è stata la seconda edizione del Progetto Giovani. Eppure, quell’anno Marco ha partecipato poco, così poco che Marzia, allora responsabile della segreteria organizzativa del Progetto, voleva espellerlo. All’epoca non c’era ancora un limite massimo di assenze, e così Marco è arrivato fino alla fine del percorso.
«Ma perché partecipavi poco?» lo interrompe Francesca.
Marco si stringe nelle spalle. Perché partecipava poco? Perché dopotutto era un adolescente, e a quell’età ci si avvicina alle cose con slancio per poi ritrarsi di colpo, e così faceva lui: si appassionava fino a consumarsi e il giorno dopo non ne voleva più sapere. È un’età in cui ogni cosa sembra urgente e, subito dopo, irrilevante. Il suo non era disinteresse: forse voleva soltanto capire se quel posto, quella gente, potessero somigliargli un po’. O forse aveva paura che gli somigliassero davvero.
Comunque, arrivato alla fine del Progetto Giovani, si è pentito di non aver partecipato con costanza agli incontri; l’ha detto anche a Giorgio Guala, quasi scusandosi, e gli ha chiesto se potesse ripetere l’anno. Giorgio, che era un uomo di poche parole, l’ha guardato un attimo e poi ha scosso la testa: la risposta era no. «Ma» ha aggiunto, «puoi tornare il prossimo anno come tutor».
Lì per lì Marco si è limitato a sorridere, convinto che Giorgio stesse scherzando. Tutor lui, che si era presentato svogliato, in ritardo, con la testa sempre altrove? Ma Giorgio era serio. Che il suo fosse un modo di metterlo alla prova?
Marco ci ha pensato per giorni. L’idea di diventare tutor lo paralizzava, perché fare il tutor significava avere un gruppo di ragazzi che ti guarda come si guarda una guida; ma alla fine ha accettato, forse solo per non rimanere indietro, per non lasciare che la vita gli scorresse accanto. Ricorda ancora quel primo giorno come tutor, le sedie in cerchio, le voci dei ragazzi alle sue spalle. Chiusa la porta dell’aula, si è chiesto come avrebbe potuto condurre un gruppo di quasi coetanei, ma poi ha inspirato a pieni polmoni, si è voltato e ha preso posto nel perimetro del cerchio.
E menomale che aveva accettato. Se non l’avesse fatto, durante la seconda annualità, quella in cui i gruppi dovevano ideare un progetto da proporre alla città, non avrebbe mai contribuito all’ideazione di un festival interculturale che da simulazione, da utopia messa su carta, sarebbe diventato realtà. Marco ricorda benissimo un’estate passata quasi interamente in sede, a progettare sotto la guida di Giorgio B.
Il piccolo gruppo che Giorgio coordinava avrebbe preso il nome di Alessandria a colori: si parlava di migrazioni e di interculturalità in una città che, proprio in quegli anni, sperimentava la sua prima sindaca leghista. Era un modo concreto di tenere insieme pensiero critico e pratica, aula universitaria e piazza, Progetto Giovani e Giovedì Culturali, e Giorgio ricopriva un ruolo radicale, politico, che faceva da motore per tutto il gruppo.
«Ma come mai hai cambiato idea sul Progetto?» gli chiede Francesca. «Perché hai chiesto di rifarlo?».
Marco non ricorda se c’è stato un momento di rottura che ha funzionato da soglia. Ricorda però qualcosa che ha fatto Marzia, al secondo o terzo incontro del percorso. L’ha chiamato per nome. Marco, nell’udire quella che era poco più che una sconosciuta pronunciare il suo nome, si è quasi commosso. Marzia ha creato uno spazio, in quella stanza, che era solo di Marco e di nessun altro. Era una forma di riconoscimento. Più tardi lui avrebbe scoperto che in realtà Marzia, ancora prima che gli incontri del Progetto Giovani cominciassero, memorizzava i nomi di tutti i partecipanti. Già ai colloqui, si sforzava di associare alla faccia di ciascuno dei ragazzi il nome e almeno due o tre loro caratteristiche, perché poi avrebbe dovuto smistarli nei gruppi, e i gruppi, come le ripeteva Giorgio Guala, dovevano essere ben assortiti – gli amici, per esempio, dovevano essere separati. Chiamarli per nome, ricordare certe loro caratteristiche era un modo di investire su di loro, di investire sulle persone. Questo ha sempre colpito Marco, e forse è stato soprattutto questo a tenerlo agganciato all’associazione.
Quindi, che fare con quel ragazzo? Marco non può offrire una soluzione immediata al problema, ma dice a Francesca di investire su di lui. «Chiamalo per nome, ricordagli che è indispensabile, fai in modo che al gruppo lui senta di appartenere».
Qualche mese dopo, durante uno degli ultimi incontri del percorso, Francesca e il suo gruppo si siedono in cerchio. È l’attività conclusiva: ognuno deve scegliere una parola per descrivere la propria esperienza. Quando arriva il suo turno, il ragazzo resta in silenzio per qualche secondo. Poi dice soltanto: «Frustrazione».
Le altre teste nel cerchio si voltano verso di lui.
«Ma frustrazione positiva» specifica.
Dice che nel corso di quell’anno si è reso conto di quanto lavoro su se stesso deve ancora fare, che inizialmente l’ha sopraffatto. Era troppo lavoro, c’erano troppe cose che non andavano, come rimediare? Poi, però, continuando a frequentare, ha capito di avere le forze e gli strumenti per farlo.
Forse, in fondo, li ha sempre avuti.
Guarda Francesca, la ringrazia, ma è lei a ringraziare lui – in fondo, se è rimasto vuol dire che si fida di lei. Un paio d’ore dopo, mentre esce dalla sede insieme agli altri tutor, pensa che a volte basta davvero poco perché qualcuno resti. Un nome pronunciato al momento giusto, forse.
Fuori, mentre gli altri tutor si allontanano e spariscono nel parcheggio, s’intrattiene ancora un po’ con Valentina. L’aria è umida, la nebbia si stende intorno a loro in veli sottili, opachi. La piazza è quasi deserta, si sente solo qualche passo, più in là, e il rumore di un motore lontano.
Valentina le parla di un progetto che deve mandare entro la fine del mese. Francesca l’ascolta un po’ meravigliata: ancora non riesce a capacitarsi di come una cosa così tecnica – piena di tabelle, di numeri, di dati – come la progettazione, nelle mani di Valentina si faccia materia viva, magmatica. Le sue parole, in effetti, hanno sempre una specie di calore dentro, una fretta buona, e per qualche motivo Francesca ripensa a quando Marco, parlando di Valentina, ha usato la parola «abissi», non ricorda più perché ma capisce che è la parola giusta, perché lei vuole sempre sviscerare, approfondire, problematizzare.
Eppure non è sempre stato così. Quando Valentina ha cominciato a occuparsi della progettazione, lì a Cultura e Sviluppo, non sapeva nemmeno da dove cominciare. All’inizio…
Prossimo capitolo: Mercoledì 4 Febbraio 2026
Un programma per incontrarsi
Rivivi gli eventi del trentennale di Cultura e Sviluppo
Nel fiore degli anni: una festa lunga un giorno per celebrare i 30 anni di attività Sold Out
Piazza Fabrizio De André, 76 | Alessandria
La rivoluzione silenziosa dei legami: filantropia e patti territoriali in trasformazione
Piazza Fabrizio De André, 76 | Alessandria
OnStage (nON) STAre a GuardarE
Piazza Fabrizio De André, 76 | Alessandria
Una transizione infinita? Politica ed economia dalla fine del Novecento a un futuro da riprogettare Ultimi biglietti disponibili
Piazza Fabrizio De André, 76 | Alessandria
SCUOLA NUOVA, VITA NUOVA? Viaggio per genitori e ragazze/i nel mondo della scuola superiore
Piazza Fabrizio De André, 76 | Alessandria
Oltre i limiti della nostra intelligenza
Piazza Fabrizio De André, 76 | Alessandria
Matteo Bussola presenta ‘Il talento della rondine’ al Progetto Genitori
Piazza Fabrizio De André, 76 | Alessandria







