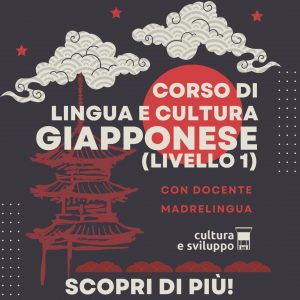“Le macchine non sono troppo poco potenti per essere simili a noi? Al contrario, le macchine sono troppo potenti, noi abbiamo dei limiti che ci caratterizzano e che le macchine non hanno”. Così Andrea Moro, professore ordinario di Linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria Iuss di Pavia e alla Scuola Normale di Pisa, ha descritto la differenza di apprendimento tra il cervello umano e quello artificiale durante il primo incontro della scuola di politica PopolX.
I temi principali della serata sono stati due: le differenze di apprendimento linguistico tra bambini e macchine e il perché le lingue impossibili esistono per noi ma non per l’Intelligenza Artificiale. Moro ha aperto il dibattito raccontando il mito di Babele e i limiti del linguaggio, sottolineando come un linguista americano, nel 1957, sembrava aver dato una sostanza formale alla confusione delle lingue e quindi alla Babele. Il professore ha spiegato che “la sfida vera è perché, per capire ciò che è possibile, conviene talvolta spiegare l’impossibile.”
Per parlare del paragone di apprendimento linguistico tra bambini e macchine, il linguista ha utilizzato l’esempio della mente staminale dei bambini, teoria secondo cui gli esseri umani nascano con una mente predisposta ad apprendere qualsiasi lingua. Si tratta di un pensiero ideato da Noam Chomsky, uno dei padri della linguistica moderna, il quale sosteneva che i bambini possono acquisire grammatiche comparabili con una rapidità sorprendente, suggerendo un’innata “capacità misteriosa” e una predisposizione biologica all’apprendimento linguistico.
È anche vero che parte dell’apprendimento del linguaggio consiste nel dimenticare le grammatiche non compatibili con l’esperienza, assimilando una lingua e scartando quelle non coerenti, processo a cui l’intelligenza artificiale non è soggetta. L’IA non distingue tra lingue impossibili e possibili. Infatti, ponendo una domanda con una regola grammaticale impossibile a ChatGpt, la macchina ha risposto senza problemi, evidenziando, in questo modo, un limite esclusivamente umano.
Dunque, quali differenze intercorrono tra i due processi di apprendimento? L’apprendimento umano avviene attraverso un meccanismo che consiste nella riduzione delle condizioni sinaptiche non necessarie. Al contrario, le macchine utilizzano tutto quello che hanno impiegando il minor tempo possibile.
Ma questa supremazia delle macchine può dare origini a dilemmi etici? Innanzitutto, va detto che alcune tecnologie, come il neuroimaging, hanno risvolti positivi sul miglioramento della comprensione del pensiero umano. Sicuramente, le scelte etiche sull’uso delle tecnologie sono fondamentali: si pensi, ad esempio, al potenziale che l’IA avrebbe nell’aiuto di coloro che si trovano in uno stato di difficoltà, ma che spesso è accompagnato da un rischio di invasione della privacy (intercettazione del pensiero).
In conclusione, l’intervento del professor Moro offre una riflessione profonda sul linguaggio, l’intelligenza artificiale e la condizione umana, con importanti implicazioni sia per la scienza sia per la politica, incoraggiando, da un lato un approccio critico e multidisciplinare all’interno di un dibattito aperto e consapevole e dall’altro invitando tutti noi a non dimenticare che i limiti della nostra mente non solo ci rendono umani ma individui unici.